di Costanza Fusi
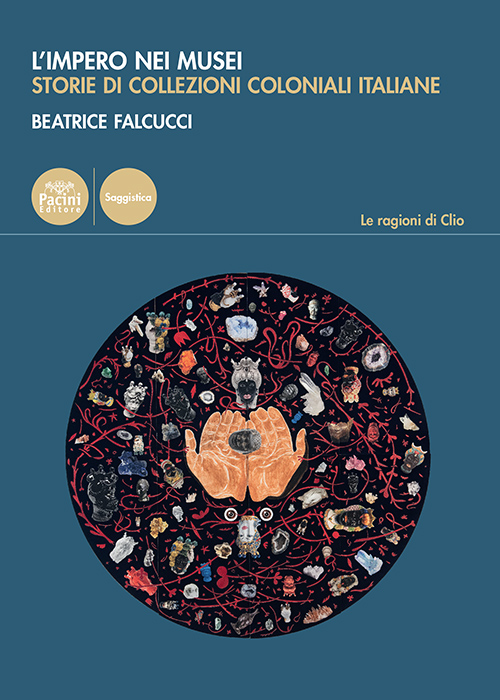
Beatrice Falcucci, L’Impero nei Musei. Storie di Collezioni Coloniali Italiane
Pacini Editore, Pisa, 2025
Scrivere oggi una monografia dedicata alla storia della cultura materiale di origine coloniale nei musei italiani significa inserirsi nel vivo di quel dibattito sulla decolonizzazione che la vede essere allo stesso tempo soggetto, approccio, necessità, funzione e rivoluzione all’interno delle istituzioni culturali e della società tutta.
A livello globale, nei musei – e non soltanto quelli di origine antropologica o etnografica – prende sempre più forza un’estrema urgenza di includere sguardi e contesti plurali. In quello che è un vero e proprio “laboratorio” della decolonizzazione, si moltiplicano le proposte per un ampliamento delle pratiche legate alla memoria coloniale, che comprendano azioni e re-azioni sempre più innovative e diversificate, sempre più spesso invocando la sensibilità degli artisti e l’aiuto di sfaccettate e poliedriche figure professionali. In questo contesto, con un rigore metodologico invidiabile, l’autrice Beatrice Falcucci, nel volume L’Impero nei musei. Storie di collezioni coloniali italiane (2025) recentemente pubblicato da Pacini Editore per la collana Le ragioni di Clio (diretta da Massimo Baioni e Fulvio Conti), si avvale della forza e della stabilità della pura ricerca storico-documentaria per regalarci un’analisi, per la prima volta completa, delle eredità del colonialismo.
Chiunque abbia tentato di definire ciò che è stato il colonialismo si è posto interrogativi che, ancora oggi, difficilmente trovano risposte in ambito accademico. Vi è, nelle narrazioni attorno alla cultura materiale originaria del periodo coloniale, una complessità intrinseca: si parla di oggetti dalle molte facce, punibili di rappresentare un debito non saldato e un passato di cui non andare fieri, ma anche in grado di far emergere dinamiche fortemente riflessive e pratiche di auto-critica che senza la presenza di queste testimonianze sarebbero difficilmente approcciabili e che pongono quotidiane sfide per chi ne è il detentore. La “decolonizzazione”, suggerisce Vivian Ziherl (2021) nell’articolo “What do we talk about when we talk about decolonisation?” in Decolonising Museums, sembrerebbe avere a che fare con lo sviluppo del concetto di una “storia anti-europea”, oggi imprescindibile in quelle agende politiche che rivendicano autodeterminazione dal dominio coloniale, e strettamente connesso ai dibattiti europei che nel dopoguerra mettevano in discussione la legittimità degli imperi. Nel proporre una sua particolare revisione di questa narrazione, che ha come oggetto la cultura materiale coloniale nei musei italiani, la ricerca di Beatrice Falcucci si inserisce con delicatezza nell’ampia cornice degli studi post-coloniali. Convivono infatti in queste pagine, alimentandosi a vicenda, discipline quali la museologia, la storia, l’antropologia e gli studi di cultura materiale.
Ciò che L’Impero nei musei offre ai suoi lettori è una storia del colonialismo italiano dal punto di vista espositivo, un’impresa che nessuno aveva tentato per intero in precedenza, e che sembrava insormontabile. Poche iniziali definizioni e precisazioni terminologiche delimitano il campo d’indagine del testo, che nasce come un progetto in sé davvero ambizioso; scavando con pazienza e attenzione nelle fonti, esso rappresenta una delle più dettagliate ricostruzioni delle vicende che hanno portato alla formazione, alla catalogazione, all’esposizione delle raccolte coloniali africane oggi ancora conservate – ma non sempre esposte – nei musei della Penisola.
Un testo come questo avrebbe dovuto essere pubblicato già molti anni fa. Offrendo una narrazione di eccezionale profondità, con la sua ricerca, Beatrice Falcucci è in grado di riaprire e collegare tra loro orizzonti storici e culturali in parte dimenticati e a cui non sempre si è dato il giusto peso. L’autrice sembra infatti interessata ad imparare qualcosa (che poi con chiarezza e competenza trasmette a noi lettori), da quella parte della storia italiana che finora è stata considerata quasi marginale, ma che, se ricostruita con occhio critico, permette di riflettere su alcune dinamiche fondamentali che descrivono la natura stessa del periodo coloniale nel nostro paese. Più volte minimizzato o perfino nascosto dietro lo stereotipo che, rispetto alle altre grandi potenze coloniali, l’Italia avesse un impero piccolo e quasi insignificante, il percorso dell’Italia potenza d’oltremare è stato per anni escluso da molti studi sul colonialismo europeo. A livello sociale, questo ha permesso di nascondere, con esso, anche le brutalità e le sopraffazioni perpetrate.
In questa cornice, l’approccio scelto dal volume riparte, si potrebbe dire, dalla “semplice” ricognizione dei lavori degli storici e museologi sul colonialismo italiano, e riproduce passo dopo passo spazi e realtà dell’epoca attraverso la raccolta meticolosa – e la cura – del materiale documentario da cui trae spunto e nutrimento, per ampliarsi poi con riflessioni e analisi personali di lungo respiro. A venire in soccorso di questo approccio è il filone di studi relativi alla “social life of things” inaugurato da Arjun Appadurai nel 1986: una lente d’ingrandimento puntata sulle prismatiche dinamiche sociali e storiche di cui la cultura materiale è protagonista, grazie alla sua circolazione globale e al suo consumo. In accordo con questa metodologia di lavoro, il volume entra quindi nelle intricate trame della ricostruzione delle biografie e delle “carriere sociali” degli oggetti conservati nei musei della Penisola, compito non facile, come sottolinea l’autrice stessa, «non soltanto per la mancanza di documentazione, di archivi e registri d’ingresso all’interno dei musei stessi» (p. 368) ma anche per l’inaccessibilità di molte collezioni private e allestimenti, a volte inesistenti o persino chiusi. Ciononostante, il volume gode di una approfondita ed esaustiva bibliografia. Peculiare è la ricchezza davvero sorprendente di dettagli, restituiti con estrema chiarezza descrittiva e documentaria. Nelle pagine de L’impero nei Musei l’autrice ha infatti riportato alla luce documenti e cataloghi, carteggi, archivi, inventari di collezioni, guide di musei e testimonianze fotografiche degli allestimenti, ma anche fonti a stampa come i bollettini, i periodici d’epoca, e le testate fondate in quel periodo, che hanno formato la coscienza comune. A circa un secolo di distanza, nonostante spesso lacunose o andate in parte perdute, queste testimonianze fanno emergere anche progetti e sogni mai realizzati da personaggiinfluenti e controversi, così come le idee contrastanti di un’epoca – o, più precisamente, di più epoche – che, non sempre consapevolmente, cercava nel museo e nell’esposizione una “trasposizione creativa” della legittimità delle proprie convinzioni. Tra queste, la necessità dell’impresa imperiale di espansione in Africa, l’accaparramento delle ricchezze “fittizie” dell’oltremare e i giudizi sull’inferiorità dei colonizzati, con la pretesa di racchiudere un intero impero, un popolo, un territorio, in una singola sala.
Molti gli elementi di interesse del testo, che affiorano dalle approfondite ricerche che l’autrice porta avanti ormai da anni. Forte di una formazione storica e antropologica rilevante (con esperienze di ricerca presso prestigiose istituzioni internazionali e una tesi di dottorato in Storia contemporanea, conseguita all’Università di Firenze, vincitrice del Premio Fondazione Spadolini nel 2021), Beatrice Falcucci è in grado di osservare, con curiosità e spirito critico, l’intreccio inestricabile tra la costruzione della nazione italiana e il periodo dell’espansione coloniale.
Da questa ricerca emergono connessioni, fusioni e relazioni complesse del paese con la sua identità culturale: un caso, quello italiano, che vede la crescita e la determinazione dell’identità della nazione molto legata allo studio delle colonie, della cultura materiale originaria di quei territori, e della loro flora e fauna stesse (di cui l’autrice fa un’ampia ricognizione, riportando nel testo anche le storie di variegati erbari coloniali e orti botanici). Uno studio che andava di pari passo con lo sviluppo della disciplina etnografica italiana e dell’antropologia, utilizzate spesso come strumenti necessari per rendere più efficace il dominio coloniale. Si sottolinea infatti, in queste pagine, la rilevanza politica degli studi antropologici, colonna portante del discorso coloniale ottocentesco, che giustificava posture di superiorità e mostrava una natura propagandistica, ben evidente nelle modalità di trasmissione e interpretazione delle immagini, degli oggetti e delle pratiche. Un’antropologia che lavorava alla creazione di immaginari per stimolare la curiosità popolare, fruibili da diversi pubblici e capillarmente distribuiti nei musei della Penisola.
Al centro del lavoro di Falcucci vi è la convinzione che la “rete” di collezioni coloniali italiane possa essere letta e interpretata «come un “archivio performante” di inter-visualità coloniale» (p. 38). E i musei, che ne sono i depositari, spazi che sono stati prima luoghi di detenzione del sapere positivo e poi simboli della nazione, pertanto, come possibili chiavi di lettura di tutte quelle discipline e linguaggi che alla loro storia si sono intrecciati, per assolvere a compiti scientifici e soprattutto, come già accennato, propagandistici e identitari. Degli oltre cento musei italiani in cui sono conservate raccolte provenienti dalle ex colonie africane, l’autrice ha sapientemente costruito una mappatura. Attraverso circa un secolo e mezzo di museografia, la comparazione delle collezioni dei musei nascenti e una ricognizione di liste di oggetti con le relative provenienze (coloniali e non), Falcucci ripercorre anche la pluri-disciplinarietà della cosiddetta “scienza coloniale”, la progressione delle “scienze geografiche” nel paese, i rapporti da sempre strettissimi dell’Italia con il mare che la circonda e quelli che si svilupparono con le colonie, sia a livello politico che culturale.
La monografia affronta così l’intricato processo di formazione delle collezioni coloniali, evidenziando il carattere ambiguo e pervasivo delle raccolte – e con ciò l’intrinseca difficoltà nel definire quali siano considerabili tali – e riflettendo sul loro significato e sugli usi pubblici che ne sono stati fatti in passato, e che in molti casi permangono ancora oggi. Scrive Beatrice Falcucci: «spesso i musei e le collezioni si possono descrivere come anche coloniali, oltre che dedicati alla guerra, all’antropologia o alle raccolte civiche» (p. 33). Patrimonio difficile (e/o non desiderato, e quindi a volte rimosso) della museografia italiana, le collezioni provenienti dalle ex colonie e territori occupati in Africa (Eritrea, Somalia, Libia, Etiopia) mostrano, usando le parole di Giulia Grechi (2021), le sopravvivenze degli assetti coloniali all’interno dei musei contemporanei. Come si sottolinea più volte nel testo, l’esporre coloniale può essere presentato infatti come «un fenomeno “sfumato”, ma anche estremamente pervasivo e sfaccettato: se la penetrazione del “coloniale” in collezioni di diverso tipo appare evidente, altrettanto chiara risulta la “collezionabilità” delle colonie» (p. 33). Si crea per questo motivo un’interazione circolare tra i due concetti, che vede gli oggetti materiali essere strumenti narrativi centrali nella costruzione dell’identità nazionale italiana e nel consolidamento dell’idea imperiale.
Già nelle riflessioni di Sarah Dudley (2010) in Museum Materialities, era ben presente quanto la ri-emergenza degli oggetti come punto focale per la comprensione delle dinamiche museali e di conseguenza delle interazioni tra esseri umani e mondo materiale, avesse un grande potenziale. Da questo punto di vista, i musei italiani, come siti principali per la ricerca, oggetti antropologici essi stessi (Lattanzi, 2021) offrono un campo di studio più che adeguato.
La riflessione puntuale di Beatrice Falcucci parte dalle storie dei processi di raccolta dei materiali e dai criteri di allestimento e organizzazione dei “reperti” nei primi musei e ricostruisce minuziosamente, grazie a foto d’epoca, documenti e inventari, l’evoluzione e l’ampliamento delle collezioni, fino a portare all’attenzione dei lettori le condizioni odierne delle raccolte e il loro attuale stato di musealizzazione. Cercando di ricomporre la storia degli oggetti che arrivavano in Italia dai possedimenti africani – che si interseca alle storie di moltissimi altri oggetti, più o meno significativi, riportati alla luce nel testo – si ripercorrono gli innumerevoli scambi e acquisizioni dei musei, e con essi anche i contatti e le dinamiche relazionali tra esploratori, istituzioni, studiosi. Questo racconto fa quindi chiarezza anche su alcuni aspetti critici delle raccolte, come ad esempio le molte aporie e incongruenze ancora oggi riscontrabili sulle provenienze dei materiali, il loro smistamento frenetico e impreciso nelle varie nascenti istituzioni italiane che più sembravano atte ad accoglierli e la frammentazione delle collezioni in musei di tipologie diverse, tutt’oggi ancora a volte di difficile definizione. Così facendo, l’autrice è in grado di sottolineare come spesso la ricerca scientifica sui reperti fosse totalmente improvvisata – catalogare senza interpretare, raccogliere senza comprendere – e come la museografia d’epoca abbia contribuito più a restituire visioni fittizie che autentiche conoscenze antropologiche.
Oggetto del volume è anche intessere la trama delle connessioni tra la natura degli oggetti e chi li raccolse e vi investì tempo ed energie, caricandoli di significati. Toccando le dimensioni più personali dell’”agire coloniale” degli italiani nei territori d’oltremare, il lungo racconto di viaggio che Beatrice Falcucci propone ha la capacità di ricostruire gli intenti di chi partecipò in prima persona alle spedizioni e alle raccolte, mostrandone la natura composita: viaggiatori, militari, uomini d’affari, missionari, naturalisti, tutti coloro, insomma, che hanno riportato in Italia le loro memorie africane (tra le quali spiccano fotografie, oggetti, disegni, video, persino esseri umani). Far rivivere i protagonisti di queste storie significa riportare alla luce non soltanto le azioni di singoli individui, i miti e le vite degli uomini che hanno preso parte alla creazione dei musei, alla costruzione delle identità dei “pionieri” e dei “martiri”, ma anche le dinamiche economiche e storiche che il periodo della colonizzazione, e i desideri di coloro che ne sono stati gli artefici, hanno contribuito a plasmare. Da questa analisi viene fuori per la prima volta quindi la storia delle istituzioni, dei ministeri, delle leggi che hanno regolato la colonizzazione, delle cattedre universitarie e traiettorie professionali di curatori e direttori di museo, rilevanti per comprendere il sentire degli italiani.
Estremamente interessante risulta pertanto lo studio delle pratiche di esposizione, delle didascalie, delle nomenclature originarie impiegate nei musei e negli archivi – veri e propri strumenti di potere epistemologico nell’epoca dell’espansione italiana. Il volume si fa portavoce di una nuova consapevolezza: determinate dinamiche di linguaggio nelle categorizzazioni e nelle suddivisioni museali e d’archivio, quasi completamente ignorate in passato, necessitano di grande attenzione. In quel preciso momento storico, infatti, queste nomenclature assunsero il loro valore e significato agli occhi di chi le utilizzava, le fruiva e le sceglieva e restano pertanto fondamentali per analizzare lo Zeitgeist dell’epoca. Senza dimenticare che l’aspetto materiale del colonialismo era tangibile anche nei monumenti, nei nomi di vie e piazze, così come nei manifesti e nelle cartoline distribuite, e che essi rappresentano un punto di riferimento importante per capire che «conoscere e far proprio, anche attraverso la nomenclatura, il territorio d’oltremare significava controllarlo» (p.101).
Il testo è strutturato cronologicamente, segue infatti «gli snodi dell’esporre coloniale, tra gli anni settanta dell’ottocento e oggi, con una prospettiva di lungo periodo che intende però evidenziare le specificità di ciascun momento storico» (p. 13). Una narrazione che parte quindi dal Risorgimento italiano e ripercorre con particolare attenzione l’epoca fascista – in dettaglio gli anni 20 e 30 – e quella imperiale, terminando con una riflessione sui vari riallestimenti recenti, che mostrano quanto il presente sia ancora fortemente combattuto su quali modalità adottare nello studio e nella catalogazione delle collezioni, e che «l’esposizione museale, oggi più che mai, sembra configurarsi come terreno di scontro tra visioni del passato coloniale del Paese radicalmente diverse, e di diverse idee su come e da chi esso dovrebbe essere raccontato» (p. 374).
Ad ognuno dei momenti analizzati «corrispose un diverso modo di relazionarsi con le colonie e diverse tendenze espositive» (p. 13) e per questo Falcucci esplora le varie fasi dividendo il volume in sei corposi capitoli: I. La materialità dell’impero; II. Musei e collezioni durante la prima età liberale; III. Il nuovo secolo e l’invasione della Libia; IV. I musei coloniali del fascismo; V. La natura dell’oltremare; VI. L’impero nei musei tra passato e presente. Tocca quindi tante temporalità, modalità, obiettivi dell’Italia coloniale; dalle prime avventurose esplorazioni alle successive più irregimentate e regolamentate spedizioni con i loro obiettivi finanziari, che alimentarono leggende presentando quadri erronei o addirittura inventati di alcuni dei territori. Dal primo museo di Antropologia italiano, costruito grazie alle collezioni raggruppate a Firenze dallo studioso poliedrico Mantegazza (1869) negli anni ferventi in cui Firenze era capitale d’Italia e la competizione durante gli anni successivi con Luigi Pigorini (1876) per l’acquisizione di collezioni e reperti pensati per l’”educazione delle masse”, che formarono il Museo Preistorico Etnografico a Roma in pieno stile positivista, fino allo sviluppo delle vicende del museo coloniale, ex museo dell’Africa italiana: i suoi inventari, i cambi di nome e di sede, le perplessità e le potenzialità intrinseche nella sua stessa esistenza.
Le pagine conclusive del volume sono dedicate a un’analisi della memoria del passato coloniale, oggi «al centro dell’attenzione di un pubblico sempre più vasto, come raramente accaduto nella storia recente del Paese» (p. 375). Nuove direttive, pratiche di scambio e restituzione di patrimonio (già presenti, seppur in forme embrionali, dal secondo dopoguerra) e nuovi linguaggi critici e “liminali” nel museo hanno infatti un ruolo particolarmente delicato nella museografia contemporanea.
Sulle tracce che la presenza coloniale italiana ha lasciato nelle memorie delle persone, il volume rappresenta un punto di svolta negli studi sulle collezioni coloniali italiane, colmando una lacuna storiografica, proponendo nuovi interrogativi su cosa trasmettano ancora oggi gli oggetti africani raccolti durante il periodo coloniale e rimarcando come il loro studio possa chiarire quali discorsi, idee, teorie, essi abbiano supportato. Elegante e accurato, il testo di Beatrice Falcucci si segnala per una chiarezza espositiva che rende leggibili anche le parti più tecniche o dettagliate, senza appesantire la narrazione. Una lettura intensa, contributo di assoluto rilievo che incontra gli interessi degli specialisti ma risulta prezioso spunto anche per i curiosi e gli appassionati di storia – e storie – italiane e globali, che si affaccia con sicurezza sui confini sociali, politici e geografici della nazione. Un testo che si candida, in definitiva, a diventare lettura obbligata per chiunque voglia confrontarsi con la storia dell’Italia coloniale e con le sue eredità materiali – strumenti utili per ripensare il nostro posizionamento, come ricercatori, come professionisti museali, come generazione presente che ha la possibilità, e non soltanto l’onere, di prendere davvero coscienza, per poter “far pace” con un passato ancora in gran parte oggetto di conflitto e rimozione.
Fonti:
Appadurai, Arjun (1986): The social life of things: Commodities in Cultural Perspective. Cambridge: Cambridge University Press.
Dudley, Sarah (2010): Museum materialities: objects, engagements, interpretations. London: Routledge.
Grechi, Giulia (2021): Decolonizzare il museo. Mostrazioni, pratiche artistiche, sguardi incarnati. Milano: Mimesis.
Lattanzi, Vito (2021): Musei e antropologia. Storie, esperienze, prospettive. Roma: Carocci Editore.
Renzullo, Antonella. (2024): “Eredità (in)visibili: l’Italia coloniale in mostra,” Geolitterae. <https://geolitterae.unimi.it/2024/12/03/beatrice-falcucci-italia-coloniale-in-mostra/> Ziherl, Vivian (2021): “What do we talk about when we talk about decolonisation?”inAA.VV. Decolonising Museums. L’Internationale Books Online. <https://archive-2014-2024.internationaleonline.org/d2tv32fgpo1xal.cloudfront.net/files/02-decolonisingmuseums-1.pdf>